A blog about books from all around the world, with an emphasis on everything postcolonial.
Tuesday, December 28, 2010
"Fault Lines: A Memoir" by Meena Alexander
Sunday, December 19, 2010
"Invitation to a Beheading" by Vladimir Nabokov

Thursday, December 16, 2010
"A Matter of Time" by Shashi Deshpande

‘Deshpande is quite clear that, for her, finding her own voice meant not just a woman’s voice but a literary voice of her own: no magic realism, no concessions to “marketability”, no themes or situations that pander to a so-called Western audience, no adapting her style to what a target readership might prefer. One will not find in her novels any element of the “exotic”, a National Geographic-land-and-its-people kind of treatment of the unfamiliar. Rather than serve up a dish that experiments with the spices of the Orient, Deshpande assumes her readers’ familiarity with the everyday ingredients of her offerings, relying upon their fresh, home-cooked flavor to have readers asking for more. Her writing style is marked by an absence of flamboyant or literary flourish. Nor does she beguile us with a Merchant Ivory-like gloss on “Indian Culture.” So, she has never, for example, felt any disjunction between her social self and her literary self, of the kind that critics have noted in other women writers writing in English’
Tuesday, December 14, 2010
Lolita e il totalitarismo: "Leggere Lolita a Teheran"
Lolita e il totalitarismo: “Leggere Lolita a Teheran”
“Leggere Lolita a Teheran” è un libro di memorie scritto da un’ex professoressa iraniana di letteratura inglese, Azar Nafisi. Il libro racconta come nel 1995, dopo essere stata espulsa dall’università di Teheran per essersi rifiutata di fare lezione con il velo, l’ex professoressa decida di tenere dei seminari privati di letteratura con sette ex-allieve, tenuti nella sua grande casa di Teheran. La situazione ricorda, e lo afferma anche l’autrice all’inizio del libro, il club di “Gli Anni Fulgenti di Miss Brodie” di Muriel Spark, dove appunto una professoressa riunisce un drappello di alunne preferite attorno a sè.
I testi discussi sono classici della letteratura inglese e americana proibiti dalla Repubblica Islamica: “Il Grande Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald, “Daisy Miller” di Henry James, i romanzi di Jane Austen e, naturalmente, “Lolita” di Vladimir Nabokov. In un paese in cui si tenta di eliminare la parola “vino” da un racconto di Hemingway oppure si vieta l’insegnamento di Emily Brontë perché sembra condonare l’adulterio, la letteratura serve a creare spazi in cui conservare la propria identità in un regime totalitario che vorrebbe abolire ogni individualismo. La classe per queste donne è uno spazio tutto per sé, una specie di versione comunitaria della stanza di cui parla Virginia Woolf. Che cosa sperano di trovare nella letteratura le persone, e in particolare le donne, che vivono in un regime totalitario? Azar Nafisi dice che sperano di trovare un legame, una connessione tra lo spazio aperto dei romanzi e quello chiuso, ristretto della loro vita. Si tratta di un libro profondamente ancorato all’esperienza di essere donna in un paese come l’Iran, dove le donne sono costrette a coprirsi i capelli, non possono mettere lo smalto né indossare vestiti troppo colorati (anche se non c’è nessuna legge che lo vieti) e sono rigidamente controllate in ogni loro movimento.
Non si tratta di un libro dal particolare pregio letterario, né le riflessioni sulla letteratura inglese e americana sono particolarmente complesse. Non si tratta di un libro di critica letteraria (mi pare non vengano mai citati nomi di critici o testi canonici di critica letteraria), ma un libro di memorie raccontate attraverso i libri. Si tratta di un approccio amatoriale alla letteratura. Per Azar Nafisi e le sue allieve i personaggi dei romanzi di cui discutono spuntano fuori dalle loro pagine per diventare quasi reali (verso la fine una delle studentesse rivela che il soprannome che lei ha dato alla propria figlia è “Daisy”, mutuato da Henry James).
All’inizio del libro, l’autrice spiega che il libro che descrive meglio le loro vite nella repubblica islamica non è “1984” di George Orwell né, appunto, “Gli Anni Fulgenti di Miss Brodie”, ma “Lolita” di Nabokov. Per Azar Nafisi e le sue studentesse, infatti, la storia di Humbert Humbert, il patrigno-amante che tiene prigioniera la sua “ninfetta” succhiandole la linfa vitale e privandola di tutte le esperienze che caratterizzano l’adolescenza diventa una metafora della loro vita in Iran e delle privazioni delle donne iraniane. Dall’obbligo di portare il velo in pubblico al divieto di mangiare una mela in maniera troppo seducente, le donne in Iran vivono la stessa situazione di Lolita che, osservata come un falco dal gelosissimo “patrigno”, non ha alcuna libertà. Lolita non può parlare con gli altri ragazzi e non può fare nulla senza che Humbert acconsenta. La cartina tornasole di ciò si trova nella postfazone di “Lolita”, in cui l’autore spiega come è nata l’idea di scrivere il romanzo. Egli scrive di aver letto sul giornale una notizia riguardante una scimmia che, dopo mesi di continue insistenze da parte di uno scienziato, aveva prodotto il primo disegno fatto da un animale ed aveva disegnato le sbarre della sua gabbia. L’idea di “Lolita” nasce in realtà da un’idea per un romanzo espressa da un personaggio di uno dei suoi romanzi scritti in russo, Dar (Il Dono), del 1938. Probabilmente Nabokov ha creato un Nabokov fittizio che scrive la prefazione. Con Nabokov bisogna sempre essere sospettosi, scrive Carl R. Proffer, autore del libro Keys to Lolita, perché il lettore ingenuo finisce infilzato contro il muro come le farfalle di Nabokov (che era un collezionista di farfalle). Egli con la prefazione ci manda quindi un ulteriore indizio, non sulla genesi di “Lolita”, ma sul modo in cui dobbiamo interpretare la storia: Humbert tiene prigioniera Lolita, la violenta, la priva della sua libertà di adolescente. Lolita può essere quindi letto come l’atto solipsistico e violento di confiscare la vita di un’altra persona e modellarla secondo i propri sogni e desideri “deviati” (Nafisi usa l’espressione “distorted dreams”). Ricordiamo come Lolita sia indifferente ai tentativi di “acculturazione” di Humbert, ma come si entusiasmi per la rappresentazione teatrale del suo amante-liberatore Quilty. Come Lolita, le donne iraniane cercano di creare piccole sacche di libertà e di sfruttare ogni occasione per creare piccoli atti d’insubordinazione contro colui (o coloro) che le incarcerano.
La lettura totalitaria di “Lolita” non è poi così balzana. Martin Amis in un saggio sullo stalinismo intitolato “Koba il terribile” sostiene che “Lolita” sia un’elaborata metafora per quel totalitarismo che ha distrutto la Russia dell’infanzia dell’autore, e lo fa nonostante Nabokov dica nella postfazione al romanzo che detesta i simboli e le allegorie. Tuttavia, scrive Nabokov nelle sue “Lezioni di Letteratura”: “Quando si legge, bisogna cogliere e accarezzare i particolari. Non c’è niente di male nel chiarore lunare della generalizzazione, se viene dopo che si sono amorevolmente colte le solari inezie del libro” (p.31).
Nabokov, ricorda Martin Amis in “Koba Il Terribile”, “era appena scappato dalla Francia, sul punto di cadere in mano ai tedeschi, insieme alla moglie ebrea Véra e al figlio Dmitri. E poco prima era fuggito dalla Berlino hitleriana e di Weimar […]. E ancora prima era scappato dalla Russia rivoluzionaria. Forse perché intimoriti dal disprezzo nutrito da Nabokov per l’arte ‘di idee’, tendiamo a sottovalutare l’aspetto politico della sua narrativa. Scrisse due romanzi sugli stati totalitari (I Bastardi e Invito a una decapitazione); erano situazioni immaginarie, ma le dittature di cui Nabokov aveva fatto esperienza erano reali: quella di Lenin e quella di Hitler. E, come Trockij ricordava con compiacimento, Vladimir Nabokov (padre) era stato assassinato a Berlino nel 1922, quando Vladimir Nabokov (figlio: in Parla, Ricordo definisce gli aggressori “due fascisti russi”) stava per compiere ventitre anni; quella serata – <
Come dice Azar Nafisi nel suo libro, “Lolita” non è una critica della repubblica islamica ma va contro ogni prospettiva totalitaria. Teheran, nel caso di Azar Nafisi, ha dato nuova forma al romanzo di Nabokov: in Iran e per quelle donne questo è quello che significa “Lolita”, a prescindere dall’apparente solipsismo di Nabokov, che rifiuta, in barba a Barthes, diverse interpretazioni del libro (quella psicologica, quella romantica o quella anti-americana). Un’interpretazione azzardata con Nabokov sembra un peccato mortale; Proffer ha detto che azzardare un’interpretazione di Lolita “sarebbe più riprovevole che stuprare Mabel Glave”. Mabel Glave è una delle compagne di classe di Lolita menzionate nel libro, ma è in realtà un gioco di parole, un’allusione letteraria a qualcos’altro, come tutti i nomi nel romanzo: Mabel richiama ovviamente il francese “ma belle”, mentre “glaive”è una parola arcaica che indica un “premio”. Mabel Glave significherebbe quindi “il mio bel premio”, quello che Lolita rappresenta per Humbert e quello che probabilmente “Lolita”, il libro, rappresenta per Nabokov. Stuprare “Ma belle Lolita” è quindi un atto deprecabile.
C’è un momento in “Lolita” in cui Humbert vede una farfalla, o forse è una falena, nell’ufficio del campo estivo dove va a prendere Lolita ma non riesce a distinguerle, non gli importa. Questo è un punto importante, perché è eco di un’incapacità ben diversa, quella morale di distinguere tra una bambina, un’adolescente e una donna. Lolita che piange la notte – una scena importantissima a mio avviso ricorda questa farfalla infilzata al muro con uno spillo, incapace di scappare. Quelli che sostengono che Lolita parli della seduzione di una giovane ninfetta su un impotente professore di letteratura francese, si dimenticano quella scena, forse hanno letto “Lolita” senza leggerlo veramente.
Sempre nelle “Lezioni di Letteratura”, Nabokov scrive questo: “Un buon lettore, un grande lettore, un lettore attivo e creativo è un ‘rilettore’. E vi dirò perché. Quando leggiamo un libro per la prima volta, il processo stesso di spostare faticosamente gli occhi da sinistra a destra, riga dopo riga, pagina dopo pagina, questo complicato lavoro fisico sul libro, il processo stesso di imparare in termini di spazio e di tempo di che cosa si tratti, si frappone tra noi e la valutazione artistica. Quando guardiamo un quadro, non dobbiamo spostare gli occhi in una maniera particolare, anche se il quadro, come un libro contiene elementi da approfondire e sviluppare. L’elemento tempo non ha molto peso in un primo contatto con un quadro. Nel leggere un libro, dobbiamo invece avere il tempo di farne la conoscenza. Non abbiamo un organo fisico (come è l’occhio per il quadro) che recepisca il tutto e possa poi goderne i particolari. Ma a una seconda o a una terza o a una quarta lettura, ci comportiamo, in un certo senso, di fronte a un libro come di fronte a un quadro” (p.33).
In sostanza a mio parere “Lolita” è sì un’esperienza estetica, dove bisogna gustarsi i giochi di parole, gli enigmi e gli indizi disseminati da Nabokov nel corso del romanzo, ma anche – ad una seconda lettura, usando le indicazioni dell’autore – una metafora del potere distruttivo del totalitarismo (come non ricordare come finisce il protagonista del romanzo?). Quello che fa Azar Nafisi nel suo libro è quindi non leggere Lolita a Teheran, ma ri-leggere Lolita a Teheran, perché, a mio parere, fa esattamente l’operazione di guardare il libro come si fa con un quadro, dopo averne studiato i particolari, si allontana e riesce ad ottenerne una visione diversa, più generale.
In uno degli scorsi incontri è stata sollevata la questione del “implied reader”, il lettore implicito. Questo viene prefigurato prima dall’autore, ma poi il testo ha una sua imprevedibilità: può venir letto da persone a cui l’autore non aveva pensato, può venir interpretato, modificato, finanche mal-interpretato dai suoi lettori. E’ quello che è successo a “Lolita” nel caso che stiamo prendendo in questione. Di certo Nabokov non si sarebbe aspettato che il libro venisse letto in Iran (d’altronde, con tutte quelle citazioni letterarie, il “lettore ideale” per Nabokov è un erudito europeo che parli correntemente almeno inglese e francese e abbia una conoscenza molto dettagliata della letteratura occidentale).
Thursday, December 9, 2010
Cosa ho fatto ultimamente?
Thursday, November 25, 2010
Gender and sexuality in Katherine Mansfield and Jane Campion's "The Piano"
This essay will focus on attitudes towards gender and sexuality in some of Katherine Mansfield’s short stories and in Jane Campion’s The Piano.
Katherine Mansfield is probably the most prominent New Zealand female writer. She was born in Wellington into a bourgeois family but left her country to complete her education in London. She returned to New Zealand in 1906, only to leave it permanently a couple of years later. She was weary of the provincial lifestyle of her home town, Wellington, and was longing for the mundane life she had experienced in London. In Europe she led a rather bohemian life; she married a man and left him the following day, and had a miscarriage. She finally married John Middleton Murry, the editor of an avant-garde magazine called Rhythm. She continued to write, turning to her childhood memories in New Zealand, thus creating some of her most powerful stories. She contracted tuberculosis and died at the age of 34. She is considered one of the best short story writers of her period and an innovator of this genre during the modernist period.
‘Prelude’ (1918) and ‘At the Bay’ (1922) deal with the Burnells, a family that Mansfield created for some of her short stories, thinking of her own childhood. They are rather long short stories, both divided into twelve sections, each with a different focus. They look like chapters of a novel; in fact, Mansfield tried several times to write a novel, but never managed. However, ‘Prelude’, ‘At the Bay’ and perhaps ‘The Doll’s House’ deal with the life and interior struggles of the family. Mansfield’s stories are often fragments or recollections, dealing with everyday life and ordinary people. In most of her short stories nothing happens, or it is better to say that everything happens, but only inside the characters’ minds: there is no plot, and yet the story is ‘carefully constructed around a moment of crisis or turning point[1]’. Mansfield’s prose has been described as quite distant from Jane Austen’s, but the two writers are close for their ‘ironic pictures of sophisticated society’s pretensions and conventions’[2]. Mansfield was, in fact, concerned with the role of women in society and their relationships with their husbands and family.
Linda and Stanley Burnell is an apparently happy couple with three children. Linda is a mother and a wife, but she is not happy in her role. She truly loves and respects her husband, but is worried by the responsibilities of the house and by the task of delivering children. This is aggravated by the fact that she does not seem to love them. Referring to the furniture and objects to be moved to the new house, she says: ‘”These are absolute necessities that I will not let out of my sight for one instant”’ and then, realizing that there is not enough room for her children, adds: ’”We shall simply have to leave them. That is all. We shall simply have to cast them off”’. For a moment, the reader thinks that she is still speaking about the furniture, but then you realize she prefers to get rid of her children instead of some furniture. ‘A strange little laugh flew from her lips[3]’ as she knows that she cannot possibly get rid of them, except for a few hours. Linda is certainly not the mother someone would expect to find in a story set in 1880s in New Zealand: she does not seem to be fit for domestic life, nor for the role of a loving mother. She is rather selfish and wants to run away from her home: ‘Her clothes lay across a chair. […] Looking at them she wished that she was going away from this house, too. And she saw herself driving away from them all in a little buggy, driving away from everybody and not even waving’ (p.25). She states that her three pregnancies weakened her and for this reason she is dispensed with doing any housework. She suffers from headaches and does not want to eat anything, but this all seems to be an excuse to make people pity her: ‘”Are those the children?” But Linda did not really care; she did not even open her eyes to see’ (p.19). What scares Linda most is pregnancy, and even though she loves Stanley, she is overwhelmed by his vigour and sexual appetite: she spends her time ‘calming Stanley down’ and ‘in the dread of having children’ (p.222). Even though Mansfield does not tell us of the sexual intercourse between Linda and Stanley in ‘Prelude’, it is clear that they are having one through the way Linda calls Stanley ‘Mr. Business Man’ to please him, and, when he draws her near, she says with a faint voice: ‘”Yes, clasp me”(p.23). Linda dreams of picking up a small bird while walking with her father, but the bird begins to swell and then it turns into a baby ‘with a big naked head and a gaping bird-mouth, opening and shutting’ (p.24). Mansfield’s stories are highly symbolic and Freud’s theories had a great influence at the time when the story was written. Linda is scared of having another child, and she feels that she is living a life that she cannot quite understand, nor bear. Nevertheless, the most important symbol in the story is the aloe in the garden, which could be a phallic symbol or maybe an image of female sexuality: ‘one huge plant with thick, grey-green, thorny leaves, and out of the middle there sprang up a tall stout stem’ (p.34). This plant is supposed to flower once every hundred years, and it is probably ‘attractive to Linda because of its infrequency of bearing[4]’. Mrs. Fairfield thinks that the plant may flower this year and Linda agrees. Mary Paul, in her book Her Side of the Story, suggests that ‘Prelude’ hints at the conception of the Burnells’ fourth child, who we meet in ‘At the bay’, set some time after this episode. This reading of the story allows the reader to give a deeper meaning to Linda’s dream: the unconscious knowledge of being pregnant once again. Linda’s character in the story is an unusual woman, not certainly the conventional Victorian wife/mother: she refuses the role given to her by her family, but she is unable to run away from this kind of life. She loves and at the same time hates her husband in a continuous contradiction that she is aware of, and she compares him with a dog that rushes at her: ‘”If only he wouldn’t jump at her so, and bark so loudly, and watch her with such eager, loving eyes. He was too strong for her; she had always hated things that rush at her, from a child”’ (p.54). Linda is maybe the opposite of what Mansfield was in her life, because she left husbands whenever she was tired of them, she had an abortion and a miscarriage, and she led an unconventional life far from her bourgeois family in New Zealand. Seen that Mansfield wrote these stories near the end of her short life, Linda is what Mansfield could have turned into if she would have accepted a conventional life within her family. Whether she is regretting the life she had as an intellectual in Europe, or whether she is just turning to her New Zealand childhood, she is depicting a character with an embryonic rebellion and a strong desire of escaping from her boring, oppressive bourgeois life: ‘Linda is a sensitive and imaginative woman with a second “self” beneath the self she presents to her family; all through ‘Prelude’ the second self threatens to break out’[5].
Stanley, Linda’s husband, is strong, efficient, hard-working and full of energy; as French Feminist Hélène Cixous would put it - femininity and masculinity are opposed in terms of passivity and activity, especially in the sexual sphere[6]. A symbol for Stanley’s activity is the food that Linda refuses and that Stanley avidly devours. Stanley is unaware that he is a problem to the women in his house: he is practical, as opposed to Linda’s vagueness and carelessness about things (‘”Stick, dear? What stick?” Linda’s vagueness on these occasions could not be real, Stanley decided’ p.212), and is making money by working hard. Victorian society in New Zealand was dominated by commercial initiative, by owning things and land; the men in Mansfield’s stories represent this kind of society. Not only Mr. Burnell, but also other male characters in Mansfield’s work act as though they own their wives: Mr. Hammond in ‘The Stranger’ says: ‘”I feel I’ll never have you to myself again. These cursed people”’ (p.359). Stanely feels that he is the only one who has power in the house, and even asks the women’s help to put sugar in his tea or to look for his stick. The women are therefore relieved when he leaves the house for his office.
Another interesting character is Beryl, Linda’s unmarried sister. Unlike Linda, Beryl desperately wants to find a husband, which seems to be the only fulfilment of a woman’s life at that time. She clings to beauty and clothes to find a lover, and she is constantly daydreaming of him, but it is the kind of love story to be found in magazines and romances: ‘”A young man, immensely rich, has just arrived from England. […] Who is that exquisite creature in eau-de-nil satin? Beryl Fairfield…”’ (p.22). In ‘At the Bay’ she is attracted to Mrs. Kember, which hints at a possible lesbian relationship. She accepts Mrs. Kember’s compliments as though they were from a man, but at the same time is horrified by her unconventionality: she smokes, does not have children, is married to a man ten years her junior and treats men ‘as though she was one of them’(p.128). It is a simultaneous attraction and repulsion, something which she cannot explain to herself. Mrs. Kember is not treated with sympathy in the story by the author, even though Mansfield experienced a similar life: Mrs. Kember is a predator and a seducer rather than a lover, and this is what Beryl, and her sister Linda as well, draws away from[7]. At the end of ‘At the Bay’, Beryl also refuses Harry Kember’s advances for the same reason, and in ‘The Doll’s House’ she receives a threatening letter from another man asking to meet her. Beryl is scared by predators; she does not want to be the object in a relationship and this is what women are supposed to be in Victorian society.
Mansfield’s characters are not satisfied with the role of wives and mothers, but unmarried women are not happy either, though Mrs Stubbs states that ‘freedom’s best’ (p.231). As we see in another story called ‘The woman at the store’, killing one’s husband is not a good solution, because the woman that we encounter at the store is withered and burdened with a child whose mind is ‘diseased’. The same ‘wax-doll’, ‘who knew one hundred and twenty-five ways of kissing’ is now obliged to look after her store and never meet other people. Mrs Kember, with her coldness and unconventional behaviour, is maybe the only one who does not care for Victorian codes and has turned her passive role into an active one, but the price she pays is being shunned by everyone. In Mansfield’s stories the only weapon that women can use safely is withdrawal, like Mrs Hammond does in ‘The Stranger’ when telling her husband of her innocent affinity with a man that she encountered on a ship voyage.
In order to meet a woman that breaks away from Victorian codes, i.e. turning her sexual passivity into active sexual power, we must look at the tale of the sexual awakening of a 19th-century woman, as seen from a late 20th century perspective. In The Piano by Jane Campion (1993), Ada is a Scottish woman who travels to New Zealand to meet her husband in a marriage arranged by her father and therefore becomes her husband’s property. Ada is mute and her only means of expression is a piano, which she has been playing since the age of six. When she arrives to New Zealand with her daughter, Flora, we are struck by the absurdity of her Victorian dress and her grand piano in such a wild place. Stewart, her husband, does not understand her need to play the piano and asks himself why she was playing the kitchen table, assuming that she might be mad. Ada is severe and uptight, stuck in her black Victorian dress, but when she is alone with Flora she changes: mother and daughter speak in their sign language and Ada tells stories to Flora. Ada’s muteness could symbolize many things: maybe that is how men want women, ‘silent and confined[8]’, or maybe it is her ‘ultimate act of resistance[9]’ to other people’s desire to dominate her: another form of withdrawal from men’s power. In fact, at the end of the story, when she is supposedly happy with Baines, she learns to speak, and no longer wears that dark and oppressive dress: she has freed herself.
With Stewart, Ada is ‘shown to be vulnerable to being treated as a sexual and emotional commodity[10]’and everything is bought and sold in 19th century New Zealand: the piano for land, the same piano for Ada’s sexual services, and even Ada is sold to Stewart as a wife. On the other hand, Baines is Stewart’s exact opposite: he immediately understands Ada’s way of expression through the piano, and he does not want Ada only sexually, but he also wants her to care for him: ‘I’m giving the piano back to you. I’ve had enough. The arrangement is making you a whore and me wretched. I want you to care for me, but you can’t’. Even though at the beginning of Ada’s agreement to have her piano back we may consider Baines as a pervert, an ignorant man living almost like a savage, we slowly understand that he has a soft side. Maybe his closeness with the Maori people allows him to be more sexually free than English people. The difference between Stewart and Baines is shown immediately from the first scene at the beach, when, asked by Stewart, Baines says that Ada looks very tired, although Stewart was asking about more practical things. His incapability to understand Ada shows ‘the collision of female sensibility with pioneer pragmatism’[11]. Steward, however, is an unusual character in films: he seems to act like he has the power with Ada, but he does not manage to rape her or keep her away from Baines. He is weak in the end: he does not kill Baines and lets Ada go, and when he desires to cut off her hand, he manages to cut off only her fingertip. The opposition between Stewart and Baines could be compared with the opposition between Stanley and Jonathan Trout in Mansfield’s ‘At the Bay’. During the conversation between Linda and Jonathan Trout we perceive that the separated worlds of men and women come closer, because Linda and Jonathan have some affinities: Jonathan does not like to spend his day at work like Stanley, and Linda appreciates this. Moreover, he is attractive, full of ideas and fond of music. He does not seem to care only about practical things and is not as possessive as Stanley. Despite this, Linda has no courage to leave Stanley for Jonathan and she asserts she truly loves her husband. Jonathan, on the other hand, when asked why he is not leaving his job at the office, answers: ‘”Why don’t I fly out again? There’s the window or the door or whatever it was I came in by. It’s not hopelessly shut – is it? Why don’t I find it and be off? Answer me that, little sister. […] For some reason” […] it’s not allowed, it’s forbidden”’ (p.238). It is indeed this inexplicable impossibility to escape that blocks Linda and the other characters in Mansfield’s story, but this possibility is opened for Ada in The Piano by Baines.
Through Baines, Ada regains her sexuality and has the strength to take an active role in her relationship with Stewart. She tries her new active sexuality on him, though unsuccessfully, and eventually leaves him. What Linda does not achieve in Mansfield’s short stories, Ada does in the movie, even though she ends up being the ‘town freak, which satisfies’, according to her. She learns to not care about Victorian codes and conventions (both Ada and Baines are still married), and she seems to be finally fulfilled. Nevertheless, the ending of the movie is open to a different interpretation. While Ada is going away with Baines on a canoe, she asks to throw her piano overboard and her foot gets caught in a rope and she is thrown overboard with the piano. This could have been accidental or not, depending on the interpretation that the spectator gives to end of the movie. What is certain is that one is left with doubts about Ada’s degree of happiness with Baines.
In conclusion, Mansfield’s short story challenges mainstream attitudes toward gender and sexuality in terms of inner feelings of the characters she creates, even though they are not able to rebel completely against the restrictive society in which they live. On the other hand, Campion’s movie, which was shot in the 1990s but is set in the same Victorian era, can show a complete rebellion and sexual liberation of the character on screen, maybe because it is a contemporary reading of the same past. However, the two works show strong feminine characters and display the feminine world and sensibility in a similar way, giving us a perception of life for women in that period.
[1] Boddy, Gillian Katherine Mansfield: The Woman and the Writer. Ringwood, Victoria: Penguin Books Australia, 1988 (p.170)
[2] Ibid. (p.171)
[3] Mansfield, Katherine Collected Stories of Katherine Mansfield. London: Constable, 1945 (p.11)
[4] Hanson, Clare and Andrew Gurr Katherine Mansfield 1988. London: MacMillan Press, 1988 (p. 52)
[5] Murray, Heather Double Lives. Women in the stories of Katherine Mansfield. Dunedin: Univeristy of Otago Press, 1990 (p.51)
[6] See Hélène Cixous’s feminist theory in Marks, Elaine and Isabelle De Courtivron, eds. New French Feminisms. London: Harvester Wheatsheaf, 1981
[7] see also Fullbrook, Kate Katherine Mansfield. Brighton: Harvester Press, 1986 (p.113)
[8] Polan, Dana Jane Campion. London: British Film Institute, 2001 (p.4)
[9] Polan, Dana Jane Campion. London: British Film Institute, 2001 (p.32)
[10] Margolis, Harriet (eds.) Jane Campion’s “The Piano”. Cambridge: Cambridge University Press, 2000 (p.72)
[11] Polan, Dana Jane Campion 2001. London: British Film Institute, 2001 (p.4?)
Sunday, November 14, 2010
“Changing My Mind. Occasional Essays” by Zadie Smith

Genre: non-fiction, essays
Country: UK
It is unusual for a collection of essays to be so personal, but it’s undeniable that you will find out more about Zadie Smith’s private life by reading this than you did in the three novels she has written so far (and if you haven't read them just run to the nearest bookstore!). You discover many things about her family and her background, her “too old” white father and her younger brother for example, but you also learn about her passions (old cinema, stand-up comedy, Vladimir Nabokov and much more).
This collection is divided in four parts: Reading, Being, Seeing and Remembering. The best essay – and in a sense the most challenging – is the one about Nabokov, one of her favourite writers and it is of course in the first section, Reading. Smith argues that Roland Barthes’s “The Death of the Author” and Nabokov’s masterpieces (she admits of being a “Pnin” nerd herself!) don’t quite agree with each other. She used to get excited at Barthes, we all do. We tend to get excited at his accessibility and at his infinite possibilities. Zadie herself has indulged in writing essays like “Please Sir, Can I Have Some More: Bulimic Rejections of Self in Oliver Twist”. Nabokov, with his aim at directing the reader exactly where he wants without him realizing anything, sort of denies Barthes’s assumption that the author has lost its importance and the reader has the complete power. She has found this after reading tons of Nabokov of course, not just “Lolita”, like most of us have done*. That’s how she changed her mind about the death of the author, thanks to Vladimir Vladimorovic.
But Zadie Smith has changed her mind about other things too. One of these things is her father, whom she portrayed in her first novel in a comic and slightly vulgar way (her words). Now that he has passed away, she writes about him in two or three essays, relating about him storming the beach at Normandy during World War II (“Accidental Hero”) and about his passion for stand-up comedy, which he passed on to his immediate family (“Dead Man Laughing”).
Zadie Smith also writes, amongst other things, of E.M. Forster and his status of “middle manager”, because he was a sort of bridge between classes, sometimes writing for an ideal audience of people who might have stumbled on one of his novels by chance. Zadie’s passion for Forster stems out of the book, and so does her love for Katherine Hepburn (“Hepburn and Garbo”), Anna Magnani (“Note on Visconti’s Bellissima”) and David Foster Wallace (“Brief Interviews with Hideous Men: The Difficult Gifts of David Foster Wallace”), the latter also recently passed away.
Another outstanding and engaging essay in the collection and one I have to name in this post is “Speaking in Tongues”, based on a lecture she gave at the New York Public Library, in which she relates of people who speak in different accents, including her, Barack Obama and Eliza Dolittle. I had always wondered why Smith had such a posh accent, coming from a working-class environment and here I got my answer. She got it at Cambridge where she went to college and in this process she lost her original Willesden accent.
* Nabokov is one of the most popular authors amongst Anglophone readers of a certain “weight”, but he’s just the obscure Russian-born writer of “Lolita” to Italian readers. Or so it seems to me.
Friday, November 5, 2010
"La mia casa è dove sono" di Igiaba Scego

Genere: autobiografia/memoir
Paese: Italia
Il nuovo libro di Igiaba Scego è per molti sensi diversissimo da "Oltre Babilonia". Ovviamente la Somalia c'è (e come potrebbe non esserci!), ma questa volta si tratta di una storia autobiografica. Un "bildungsroman", come l'ha definito Michael Braun nella recensione uscita questa settimana su Internzionale. Igiaba è nata a Roma da genitori somali e ha una famiglia sparsa in giro per il mondo. Il racconto inizia infatti "in una casina incasinata di Barack Street a Manchester", dove vive il fratello di Igiaba. Non vi dico qual è la piccola epifania di Igiaba, ma se vi dico che riguarda una scatola di pastelli e le due città che le stanno più a cuore potete già intuire qualcosa. I titoli dei capitoli hanno nomi come Piazza "Santa Maria Sopra Minerva" e "La Stele di Axum". Il libro si configura quindi come una specie di geografia dell'identità di una giovane italiana nera, cresciuta all'ombra del Colosseo ma che non ha mai mangiato le penne all'amatriciana (perché c'è il maiale, scemi, cosa pensavate, che non si fosse ancora "integrata"?).
E' un racconto che non ha paura di parlare dei momenti più bui dell'adolescenza, dei drammi del "caos somalo" e della diaspora, fino alla bulimia. Quello che mi piace di più di questa scrittrice, ma mi pare di averlo già scritto in un altro post, è che in un suo libro ci mette dentro tutto quello che le piace (e anche quello che la fa arrabbiare): Chico Buarque, lo Stadio Olimpico, Malcolm X, le fiabe somale…
E' un libro che mi piacerebbe regalare alla biblioteca del mio paese, che è anche la biblioteca scolastica, perché credo sia un’ottima lettura per i ragazzi.
Vi lascio il link di un’intervista all’autrice uscita su Nazione Indiana (e per una volta non c’entra l’India), dove si parla della situazione dell’editoria e della cultura in Italia. In particolare dice una cosa che ho sempre pensato anch’io sulle sezioni dei quotidiani dedicate alla letteratura:
Le terze pagine dei giornali sono spesso per la sottoscritta una delusione
assoluta. Non tutte naturalmente, non sono il tipo da fare di tutta un’erba un
fascio. Però noto la tendenza dei giornali (soprattutto di quelli più grandi) di
fare più pubblicità che critica. Non libri quindi, ma merci. Sto cominciando a
diffidare dei paginoni e delle interviste al “divo” letterario di turno (che
stranamente sono quelli che scrivono noir. Mai che un paginone sia dedicato alla
poesia per esempio), sto cominciando a non leggere più i paginoni.
E poi sugli aiuti e le sovvenzioni agli scrittori:
Servono spazi, fondi, sovvenzioni. Per esempio in Italia per gli scrittori non c’è quasi nulla. Parlando con scrittori stranieri noto sempre come loro hanno più possibilità di poter mantenere la scrittura senza troppi sacrifici. Hanno un indotto per esempio nelle università, hanno accesso a borse di studio, hanno la possibilità di fare delle residenze all’estero. Io quando parlo con qualche scrittore straniero mi sento sempre un po’ in imbarazzo. Qui in Italia a volte fare lo scrittore è considerata una perdita di tempo. All’estero c’è un certo rispetto invece.
E se non siete ancora contenti c’è anche il link all’intervista di un’amicona cantante di Igiaba: l’italo-etiope- somala Saba Anglana.
Friday, October 29, 2010
"Lolita" di Vladimir Nabokov

Nabokov scriveva i suoi romanzi a matita su delle “index cards”, le tessere per fare gli schedari.Vi scriveva pezzetti di prosa e dialoghi, poi mescolava le carte e gli usciva il romanzo. Era un appassionato scacchista (come Kubrick) e creava problemi di scacchi da pubblicarsi sulle riviste, amava giocare a tennis (se avete letto “Lolita” farete un cenno di assenso) e collezionava farfalle, molte delle quali consegnava al museo di storia naturale. Era noto per le sue “opinioni forti” (per esempio odiava Freud, perché troppo “fallico”) e di sé stesso disse “I think like a genius, I write like a distinguished author and I speak like a child”, ovvero “Penso come un genio, scrivo come un illustre autore e parlo come un bambino”. Altri suoi romanzi importanti sono “Pnin” e “Ada”.
Friday, October 22, 2010
“Controvento” di Angeles Caso

Genere: romanzo
Angeles Caso è figlia di un eminente filologo, dice la breve biografia nell’aletta che esce dalla quarta di copertina di “Controvento”, ed ha deciso di diventare scrittrice per regalare un finale alla ballata di Arnaldo, un incompiuto spagnolo del Cinquecento che il padre le raccontava per farla addormentare. Diventata scrittrice a tempo pieno, Angeles Caso ha deciso di scrivere un romanzo sulla sua babysitter capoverdiana perché qualcuno le aveva rimproverato di scrivere solo di aristocrazia. Questa decisione le ha portato fortuna, perché “Controvento” ha vinto il premio Planeta, il più importante della Spagna, e ha causato molte discussioni, dentro e fuori dal paese. Non è infatti una cosa comune che una scrittrice europea “autoctona”, scriva delle persone “non autoctone” che ci tengono la casa pulita, ci fanno trovare la biancheria lavata e stirata ben piegata nei cassetti o mettano a letto i nostri bambini. Nella mia esperienza personale, questa è la seconda lettura spagnola di questo genere: la prima è stata “Cosmofobia” di Lucía Etxebbaría, un libro che però mi ha lasciato perplessa in alcuni punti. Angeles Caso non ha scritto questo romanzo perché scrivere sul multiculturalismo “fa figo”, ne sono sicura, ma perché è arrivata alla conclusione, forse dopo un suo percorso personale di dolore e di crescita, che la donna che le spolverava la casa e che badava ai bambini aveva una storia straordinaria alle spalle, una storia degna di essere raccontata, a differenza delle nostre banali esistenze vissute “nella bambagia”, a cui noi nonostante tutto diamo molta importanza. Essendo il libro in larga parte preso da una storia vera, alle volte ha le banalità che la verità ci riserva: São è una ragazzina studiosa ed intelligente che è costretta a lasciare la scuola prima del tempo per guadagnarsi il pane e quando le viene offerta l’occasione giusta emigra in Europa, lavorando come cameriera o donna delle pulizie e subendo anche qualche episodio di razzismo.La storia è popolata esclusivamente da donne, che vivono in un mondo completamente estraneo a quello degli uomini, che qui sono contorno, spesso privi di comprensione ed empatia. Assorbiti dall’incombenza di portare il pane a casa e comprarsi una casa al paese natale, trattano spesso le donne come zerbini, alzano la voce e le mani sulle loro compagne, privandole di ogni diritto ad esprimere la loro opionione. Non solo la protagonista ma anche Natercia, Jovita e Liliana sono donne forti (ecco che mi esce un parallelo con le tre donne forti di Marie NDiaye), che riescono a stare in piedi anche senza l’aiuto di un marito, di un uomo. “Controvento” è in altre parole un inno alla forza di noi donne, alla nostra capacità di rinascere dalla cenere e al nostro spirito di solidarietà, che ci sorregge anche nei momenti più bui.
Monday, October 11, 2010
La legge sul prezzo del libro che danneggia i più deboli
 Quando entriamo in libreria vediamo spesso sconti del 10 o 15 % su tutti gli Oscar Mondadori o su quasi tutto il catalogo della Feltrinelli. Se ci fate caso, tali sconti e promozioni non vengono quasi mai fatti su libri pubblicati da editori più piccoli. Io mi sono sempre chiesta il perché e il percome di questi sconti.
Quando entriamo in libreria vediamo spesso sconti del 10 o 15 % su tutti gli Oscar Mondadori o su quasi tutto il catalogo della Feltrinelli. Se ci fate caso, tali sconti e promozioni non vengono quasi mai fatti su libri pubblicati da editori più piccoli. Io mi sono sempre chiesta il perché e il percome di questi sconti.In questi giorni un disegno di legge che regolamenta proprio questi sconti e promozioni è in dirittura d’arrivo al Senato. Sebbene la proposta di legge dell’Onorevole Ricardo Franco Levi (Pd) difenda in apparenza i piccoli editori e le librerie indipendenti, in realtà fa esattamente il contrario. Un piccolo ma agguerrito gruppo di piccoli e medi editori – che include fra gli altri Donzelli, Minimum Fax, Sellerio e Neri Pozza – sta protestando in questo senso. Alla Buchmesse, la fiera del libro di Francoforte, per esempio, si è tenuto un convegno sull’argomento invitando alcune case editrici straniere, tra cui il francese Gallimard.
La legge proposta, impone un limite di sconto del 15 % con la possibilità di fare sconti durante tutti mesi dell’anno, senza limiti (a parte per il mese di dicembre). Voi amanti dei libri direte che è troppo poco e che in tempo di crisi bisogna fare sconti più sostanziosi, invogliando gli italiani a comprare più libri. Sono d’accordo che a volte i prezzi dei libri, soprattutto di quelli appena usciti, sono ancora alti in Italia, ma il problema che voglio sollevare è un altro. Il problema è che quello sconto agevola i grandi editori penalizzando invece i piccoli e medi editori, nonché le piccole librerie indipendenti che non possono permetterselo (ecco perché l’unica libreria decente vicino a casa mia non fa mai sconti, neanche quando è il mese dei suddetti sconti dei grandi gruppi editoriali). In Francia e in Germania c’è una legge piuttosto ferrea sul prezzo dei libri, mentre in Inghilterra dove il prezzo è ancora libero le grandi catene come Waterstone’s stanno rimpiazzando i librai indipendenti per cui strade come Charing Cross Road a Londra andavano famose.
L’appello dei Mulini a Vento, così ha deciso di chiamarsi questo gruppo che riunisce appunto piccoli e medi editori e librai, sta spingendo affinché il disegno di legge sull’editoria promosso dall’Onorevole Levi venga modificato e migliorato.
Che cos’è meglio, dunque? Prezzi scontatissimi tutto l’anno sui libri dei grandi editori e semi scomparsa delle librerie indipendenti e dei piccoli editori? Oppure prezzi fissi ma tutela dei più deboli?
Sunday, October 10, 2010
"Wolf Hall" by Hilary Mantel

I am lucky enough to know quite a lot about the court of the Tudors, because I have watched “The Tudors”, an English TV show that despite being inaccurate at times gives an idea of the major characters at stake. I have also read a book recently about the “marital problems” of King Henry (“The Six Wives of Henry VIII” by Antonia Fraser). I find the Tudors one of the most fascinating dynasties in history and for sure it is the most engaging soap-opera I have ever seen. If you don’t know much about the people buzzing around King Henry at the time, I think you’ll struggle a bit with this novel. Henry’s best friend Charles Brandon whom he made duke, the powerful Cardinal Wolsey with his ambition to be Pope, the Boleyns, the Seymours and the Howards, Katherine and her ladies-in-waiting, the ambassadors, Thomas More, they all appear in the book and play their role in the development of the story. Nonetheless, Thomas Cromwell is the absolute protagonist of “Wolf Hall”: everything is seen from his point of view, despite the fact that the novel is in the third person. Usually Thomas Cromwell is depicted as a stone-cold and shrewd person, almost a villain, but Hilary Mantel depicts him as a sensitive person, fond of his family and of his protector, the Cardinal. Of course he’s ambitious and I dare say on the good side of shrewdness, if there is one. He’s learned, almost enlightened, he appreciates Italian painting and has a gift for languages. I was delighted by this book and by the world it opens on: Thomas Cromwell is not just a name on a history book, but he steps into the real world. He has passions, faults, virtues of course, doubts and secrets. And so is King Henry, Mary and Anne Boleyn, Thomas More and all the historical characters of the book. I’m waiting for the sequel that Hilary Mantel is writing (the book ends abruptly when King Henry is about to stop by the Seymour and fall in love with Jane, later to become his third wife). Much has been said about “Wolf Hall” since it won the Booker Prize, for example on the meaning of the expression “historical fiction”. It is obvious that Hilary Mantel did a lot of research to write this book, but it’s impossible for a book set in the 16th century to be 100% accurate, not only because it would ruin the literary value of the work, but also because there are many things we don’t know or we are not sure of. Were Mary Boleyn’s children actually the king’s? Did he also sleep with Anne and Mary’s mother? Did Anne make love to distinguished courtier-poet Thomas Wyatt and was she betrothed to Henry Percy, before she became the king’s mistress? Hilary Mantel resolves this by hinting at things we are not sure of as gossips of the time, but even if she changed things, I personally believe that’s alright, as long as you claim yours is just fiction.
Thursday, October 7, 2010
Nobel per la Letteratura a Vargas Llosa

Sunday, October 3, 2010
"Il Palazzo delle Illusioni" di Chitra Banerjee Divakaruni
Wednesday, September 22, 2010
V.S. Naipaul @Festivaletteratura – 10 settembre 2010
 Ed eccomi finalmente all’incontro della bisticciata tra V.S. Naipaul, premio Nobel per la Letteratura nel 2001, e la giornalista e scrittrice Caterina Soffici. Preferirei non parlarne, ma visto che ho iniziato a scrivere questi post per fare una “relazione personale di alcuni incontri interessanti a cui ho assistito”, non posso farne a meno. Anche perché molte persone che hanno letto gli articoli sui quotidiani nazionali mi hanno chiesto che diavolo è successo. Devo confessarvi che non ho capito neanch’io cosa diavolo è successo!
Ed eccomi finalmente all’incontro della bisticciata tra V.S. Naipaul, premio Nobel per la Letteratura nel 2001, e la giornalista e scrittrice Caterina Soffici. Preferirei non parlarne, ma visto che ho iniziato a scrivere questi post per fare una “relazione personale di alcuni incontri interessanti a cui ho assistito”, non posso farne a meno. Anche perché molte persone che hanno letto gli articoli sui quotidiani nazionali mi hanno chiesto che diavolo è successo. Devo confessarvi che non ho capito neanch’io cosa diavolo è successo!Prima di tutto, per chi non conoscesse V.S. Naipaul: è uno scrittore di origine trinidadense, figlio di immigrati indiani, emigrato all’età di 18 anni in Inghilterra e che ha scritto sia della sua isola natale, sia di India, sia di Africa. E’ uno degli scrittori caraibici e postcoloniali più conosciuti al mondo e, come ho scritto prima, è stato premiato con il più importante premio letterario del mondo, il Nobel. Ultimamente ha scritto soprattutto reportage di viaggio, che vengono descritti come sinceri e dettagliati. Il fatto è che l’intervistatrice ha cominciato la presentazione dal punto di vista sbagliato, sottolineando le polemiche che girano intorno al personaggio. Vi spiego tutto: V.S. Naipaul è spesso bollato come anti-terzomondista (pur venendo egli da un paese del terzo mondo), provocatoriamente anti-islamico, snob, colonialista e viene visto, da un punto di vista più prettamente personale, come una persona difficile. Caterina Soffici lo definisce “uno dei campioni del politicamente scorretto”, ricordando anche una sua dichiarazione, che però così fuori contesto può voler dire tutto e niente (per la cronaca la dichiarazione era “in Inghilterra non esistono più i domestici di una volta”). Ora, siccome l’incontro era una presentazione dell’ultimo reportage di viaggi di V.S. Naipaul intitolato “La Maschera dell’Africa”, Caterina Soffici si addentra nella polemica che questo libro ha suscitato, in particolare citando un articolo uscito sul Sunday Times e scritto da tale Robert Harris che definiva il libro “tossico, grossolano, in accurato, in una parola repellente”. Le polemiche si riferiscono in particolare ad un passaggio in cui Naipaul dice che in Ghana sono talmente affamati da mangiare i gatti (ohibò, lo si faceva anche in Italia in tempo di guerra e poi onestamente non ci vedo nulla di strano nel mangiare un gatto, quando noi mangiamo galline, mucche e cavalli) e ad un’intervista a Winnie Mandela, che rivelava alcuni particolari della politica sudafricana post apartheid che poi lei ha smentito (anzi, ha smentito di aver mai fatto l’intervista, ohibò di nuovo). Naipaul risponde garbatamente all’intervistatrice dicendo che se un decimo di quelle cose che gli vengono attribuite fossero vere, non avrebbe nessuna reputazione. Egli non ha intenzione di difendere i suoi libri contro questi attacchi, perché chi li ha letti sa benissimo che non è lui ad avere pregiudizi nei confronti dell’Africa, ma sono i giornalisti ad attribuirgli i loro pregiudizi sul continente. Detto questo l’intervistatrice avrebbe dovuto capire che non era il caso di continuare a parlare della polemica e magari focalizzare su un altro argomento. A questo punto lo scrittore si è arrabbiato, percependo probabilmente erroneamente che l’intervistatrice era prevenuta nei suoi confronti e che o non aveva letto il suo libro oppure era “troppo di sinistra” (Naipaul dice che i suoi libri sono apolitici ma che comunque viene continuamente attaccato dagli intellettuali di sinistra). Nonostante Caterina Soffici abbia assicurato lo scrittore che non era così e che lei era anche d’accordo con alcune delle cose che lui scriveva nel libro, l’atmosfera diventa tesa e astiosa, con l’autore che si rifiuta di rispondere ad ogni altra domanda della Soffici e il pubblico che si schiera ora dalla parte di uno, ora dalla parte dell’altro.
Io mi sono trovata un po’ interdetta, non avendo letto il libro in questione, né conoscendo a fondo la polemica (l’articolo del Sunday Times è tra l’altro disponibile on-l
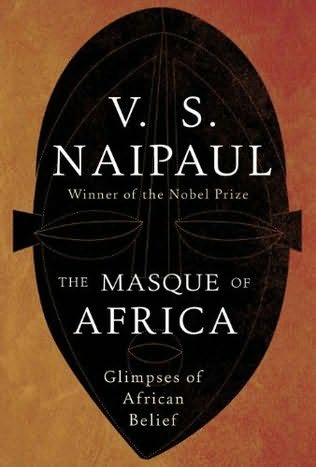 ine solo a pagamento). Penso che ci sia stato prima di tutto un grosso malinteso, causato forse anche dall’età di V.S. Naipaul (ha 78 anni e sembra star invecchiando malino). A comprovare la cosa c’è il fatto che la moglie di Naipaul, Nadira, deve intervenire due volte a sedare gli animi e a parlare per il marito, insistendo sul fatto che hanno viaggiato per un anno e mezzo in Africa per scrivere questo libro e che le polemiche che sono state sollevate denotano che non si è capito il lavoro che è stato fatto sulla magia e sulle tradizioni africane. Conclude affermando – come se non si fosse capito – che suo marito ha un’alta considerazione del suo lavoro, tutto qui.
ine solo a pagamento). Penso che ci sia stato prima di tutto un grosso malinteso, causato forse anche dall’età di V.S. Naipaul (ha 78 anni e sembra star invecchiando malino). A comprovare la cosa c’è il fatto che la moglie di Naipaul, Nadira, deve intervenire due volte a sedare gli animi e a parlare per il marito, insistendo sul fatto che hanno viaggiato per un anno e mezzo in Africa per scrivere questo libro e che le polemiche che sono state sollevate denotano che non si è capito il lavoro che è stato fatto sulla magia e sulle tradizioni africane. Conclude affermando – come se non si fosse capito – che suo marito ha un’alta considerazione del suo lavoro, tutto qui.Dopo due tentativi dell’intervistatrice di portare la discussione, ormai irrimediabilmente compromessa, su altri binari facendo una domanda sull’Islam (altro argomento altamente a rischio) e una sulla scrittura (ma avrebbe dovuto pensarci prima) a cui Naipaul non vuole rispondere, egli esprime la volontà di terminare qui la conversazione (facendo, ahimè, la figura dell’antipatico snob che si porta dietro). La vera vittima della situazione, come afferma tra l’altro la scrittrice iraniana Azar Nafisi, presente in sala e intervistata dalle televisioni poco dopo la fine dell’evento, è il pubblico, che ha pagato il biglietto per conoscere un autore rinomato, per sentir parlare di letterature e invece non ha ottenuto niente di tutto questo.
Tuesday, September 21, 2010
Zadie Smith @Festivaletteratura – 9 settembre 2010
 La giovane autrice che ha esordito a soli venticinque anni con il romanzo best-seller “Denti Bianchi”(2000) presenta in quest’occasione una raccolta di saggi chiamata “Changing My Mind” e che è sottotitolata “Occasional Essays”, per specificare la natura eterogenea degli scritti. L’incontro di questa sera, invece, s’intitola “Lettore e Scrittore: Talenti a Confronto”; ci interessa quindi la vita di lettrice di Zadie, ma anche quella di scrittrice, sia chiaro. La recente maternità le ha ammorbidito i tratti e i capelli lunghi le donano: lei e Tishani Doshi si contendono sicuramente lo scettro di donna più bella del festival. Zadie ha questa voce bassa e parla con un tono così serio che alla radio mi era sembrata un po’ snob, quasi antipatica e altezzosa. Invece da questo incontro traspare proprio l’opposto: è un po’ timida e molto umile.
La giovane autrice che ha esordito a soli venticinque anni con il romanzo best-seller “Denti Bianchi”(2000) presenta in quest’occasione una raccolta di saggi chiamata “Changing My Mind” e che è sottotitolata “Occasional Essays”, per specificare la natura eterogenea degli scritti. L’incontro di questa sera, invece, s’intitola “Lettore e Scrittore: Talenti a Confronto”; ci interessa quindi la vita di lettrice di Zadie, ma anche quella di scrittrice, sia chiaro. La recente maternità le ha ammorbidito i tratti e i capelli lunghi le donano: lei e Tishani Doshi si contendono sicuramente lo scettro di donna più bella del festival. Zadie ha questa voce bassa e parla con un tono così serio che alla radio mi era sembrata un po’ snob, quasi antipatica e altezzosa. Invece da questo incontro traspare proprio l’opposto: è un po’ timida e molto umile.L’intervistatrice, Simonetta Bitasi, confessa di non essersi preparata come avrebbe voluto per questo evento, ma la colpa è di Zadie Smith, che le ha fatto rileggere i grandi autori di cui parla Zadie nel libro, che spaziano da Vladimir Nabokov a David Foster Wallace. Solo su una cosa non è d’accordo con Zadie: Grace Kelly è migliore di Katherine Hepburn, scherza Simonetta Bitasi. Perché tra i suoi saggi, che trattano gli argomenti più disparati, ce ne è anche uno sul cinema classico.
Nel caso dell’autrice, la saggistica è più personale della narrativa: si imparano molte più cose sulla famiglia e sulla vita di Zadie Smith nel leggere questo libro che non nei suoi tre romanzi. Lei spiega, ostinandosi a parlare il suo “italiano bambino”, che il ritratto di suo padre che aveva fatto in “Denti Bianchi” era comico e leggermente volgare. Ora che lui non c’è più, sente quindi il bisogno di omaggiarlo in modo diverso. Un discorso che è uscito anche nell’incontro con Hanif Kureishi, quasi che il loro “incrocio di antiche culture” abbia portato inevitabilmente ad uno scontro generazionale. O forse no, forse è inevitabilmente quello che succede agli scrittori, che “manipolano vite” anche in modo crudele.
Parlando della lettura, Zadie Smith è convinta che ciò che si legge dai 14 ai 16 anni sia quello che conta di più, che ti caratterizza maggiormente. Dev’essere stata piuttosto precoce come lettrice perché io le mie letture più importanti le ho fatte piuttosto tra i 16 e 18 anni. La lettura ti rende parte di una comunità: due persone sono accomunate solo dal fatto di essere dei lettori. Zadie Smith si fa delle domande buffe (“Ma che legge Berlusconi?”), poi spiega che la sua non era una famiglia di intellettuali, di qui il suo entusiasmo per il mondo dell’università. Zadie Smith, infatti, insegna scrittura creativa alla New York University ed insegna ai suoi studenti che, più che scrivere continuamente o tenere diari (“Quello è cazzo” dice lei, facendo ridere il pubblico in sala), è importante mantenere sia il “sense” che la “sensibility”, cioè non sacrificare il sentimento, la passione che si prova per la letteratura, per l’approccio analitico ai testi in questione.
Alcune domande interessanti arrivano dal pubblico, per esempio sul significato degli incontri con gli autori. Zadie ammette di essere andata solo una volta ad un incontro con uno scrittore che ammirava durante gli anni dell’università. Si trattava di Martin
 Amis, che per rispondere ad una domanda sul suo lavoro di scrittore e sulla sua giornata tipica rispose che scendendo la sera per cenare i famigliari gli chiedevano com’era andata la giornata e lui gli rivolgeva la stessa domanda, ma dentro di sé pensava “As if I give a fuck” (“Come se me ne fregasse qualcosa”). Ora i due si prendono in giro (“he teases me” dice lei in inglese) per via di questo episodio, ma all’epoca era rimasta perplessa. Dice che alle volte incontrare una persona che si stima può essere deludente o banale, come è capitato a lei nelle uniche due conversazioni che ha avuto con David Foster Wallace (una sui capelli delle donne nere, su quanto spesso si piastra i capelli per la precisione).
Amis, che per rispondere ad una domanda sul suo lavoro di scrittore e sulla sua giornata tipica rispose che scendendo la sera per cenare i famigliari gli chiedevano com’era andata la giornata e lui gli rivolgeva la stessa domanda, ma dentro di sé pensava “As if I give a fuck” (“Come se me ne fregasse qualcosa”). Ora i due si prendono in giro (“he teases me” dice lei in inglese) per via di questo episodio, ma all’epoca era rimasta perplessa. Dice che alle volte incontrare una persona che si stima può essere deludente o banale, come è capitato a lei nelle uniche due conversazioni che ha avuto con David Foster Wallace (una sui capelli delle donne nere, su quanto spesso si piastra i capelli per la precisione).Alla fine ci rivela che ha in serbo per noi un romanzo di non più di 200 pagine, intitolato “NW”, il codice postale della zona di Londra dove è cresciuta, ma che ha bisogno ancora di qualche ritocco. D’altronde, con una bambina piccola, il tempo è poco e tutti le preoccupazioni vertono su questioni banali, come quale nido scegliere.
Inutile dire che ho ordinato questa raccolta di saggi (la voglio leggere in inglese) e che mi è venuta voglia di leggere come minimo Martin Amis e David Foster Wallace, che se piacciono a Zadie Smith credo (spero) che piaceranno anche a me, perché come ha osservato lei in questo splendido incontro, uno scrive quello che vorrebbe leggere.
