Nel frattempo, vorrei parlarvi di uno spettacolo di narrazione e musica avvenuto proprio nell’ambito di questa manifestazione ormai un paio di anni fa. Ho già scritto diversi post riguardo alla letteratura italiana postcoloniale e in particolare sull’Italia e il Corno d’Africa.
 , città d'origine del padre, nel 1979. Seguendo l'arte della metafora tipica della tradizione culturale etiope, scrive e interpreta spettacoli di narrazione. E' fondatrice, insieme ad altri scrittori, della rivista online "El Ghibli", che si occupa di scrittori migranti. Il suo primo romanzo è "Regina di Fiori e di Perle" (Donzelli Editore, 2007).
, città d'origine del padre, nel 1979. Seguendo l'arte della metafora tipica della tradizione culturale etiope, scrive e interpreta spettacoli di narrazione. E' fondatrice, insieme ad altri scrittori, della rivista online "El Ghibli", che si occupa di scrittori migranti. Il suo primo romanzo è "Regina di Fiori e di Perle" (Donzelli Editore, 2007).L'allestimento dello spettacolo era molto semplice: Gabriella raccontava la sua esperienza di italo-etiope-eritrea, della vita nel Corno d'Africa e del colonialismo italiano, intervallando i racconti e le letture con canzoni in amarico. Mi ha colpito molto quello che ha detto all'inizio dello spettacolo, e cioè che il colonialismo italiano in Africa è un pezzo di storia che nel nostro paese è stato scolorito fino a diventare invisibile, lasciando di quel periodo solo due concetti: quello di "italiani brava gente", che hanno costruito strade e ferrovie e trattato come pari gli abitanti del luogo, e quello che recita "Noi abbiamo usato i gas nervini per conquistare l'Etiopia". Quello che viene tralasciato, che è stato dimenticato, che non ci viene detto, sono le infinite storie personali che si sono intrecciate plasmando quel pezzo di storia. Le sofferenze e le ingiustizie raccontate da Gabriella fanno star male, toccano nel profondo, ti cambiano.
Gabriella intervallava racconti della sua storia personale con letture dal suo romanzo. Parlando della sua identità italiana, impostale dalla madre che aveva sofferto a causa di quel colonialismo italiano, Gabriella ricorda di aver sentito di essere africana al suo arrivo in Italia. A questo punto si cambia d'abito, abbandonando gli abiti occidentali per il costume tradizionale etiopico-eritreo, la testa coperta da uno scialle arancione e dei sandali ai piedi. Gabriella accende un incenso e ci porta in Etiopia. E' incredibile come i suoi lineamenti, che mi parevano così occidentali all'inizio della narrazione, siano diventati più africani con il solo ausilio di uno scialle. Gabriella canta dei canti tradizionali etiopi, accompagnata dal musicista burkinabè Gabin Dabirè, che canta anche delle canzoni nella sua lingua. Due parti d'Africa così distanti geograficamente, culturalmente e lingusiticamente che si fondono magicamente. La fine dello spettacolo è sancita da un'offerta: Gabriella ha cucinato del pane speziato etiope da offrire al pubblico. Poi scende dal palco e viene tra il pubblico: conosce tutti, persino la ragazza seduta accanto a me! Che persone squisite gli scrittori, sono come me, come te, come tutti...
Il romanzo di Gabriella Ghermandi inizia a Debre Zeit, a cinquanta chilometri da Addis Abeba, in una grande famiglia patriarcale. Un forte legame unisce il vecchio Yacob e la più piccola di casa, Mahlet. Lui la conosce meglio di chiunque altro: la guarda negli occhi, mentre lei divora le storie che lui le narra. Così, un giorno si mette a raccontarle del tempo degli italiani, venuti ad occupare quella terra, e degli arbegnà, i fieri guerrieri che li hanno combattuti. Quel giorno, Mahlet fa una promessa: da grande andrà nella terra degli italiani e si metterà a raccontare...
* termine usato dagli etiopi per indicare se stessi

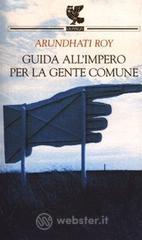
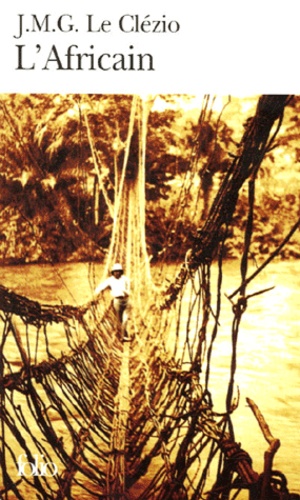

 Year of publication : 1998
Year of publication : 1998
